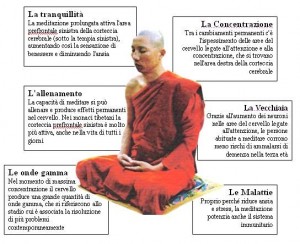Quello che sta accadendo in Svizzera, nel modo in cui molti colleghi stanno intervenendo nelle situazioni di crisi ed emergenza, offre uno spunto prezioso per una riflessione più ampia sulla psicologia dell’emergenza e sul ruolo – spesso sottovalutato – dei sanitari e degli operatori della cura.
La psicologia dell’emergenza non è (e non dovrebbe mai diventare) una psicologia “spettacolare”. Non è fatta di frasi ad effetto, di giudizi morali o di ricostruzioni a posteriori pensate per i social. È una psicologia del tempo sospeso, del qui-e-ora estremo, in cui il primo obiettivo non è capire, ma tenere: tenere le persone, tenere il contesto, tenere il limite tra ciò che può essere mentalizzato e ciò che, in quel momento, non lo è ancora.
Molti interventi osservati in Svizzera richiamano un principio fondamentale: prima della narrazione viene la regolazione. Prima del “perché” viene il “come stai adesso”. Prima dell’interpretazione viene la messa in sicurezza psicologica ed emotiva. È una postura clinica che richiede formazione, esperienza e una profonda umiltà professionale.
C’è un punto che va ribadito con forza: nelle emergenze non esistono comportamenti “giusti” o “sbagliati” in senso morale, ma risposte neuropsicologiche a una minaccia percepita come vitale. Freezing, fuga, confusione, iperattivazione o silenzio non parlano di educazione, di valori o di carattere. Parlano di sistemi nervosi sotto assedio.
È qui che il ruolo dei sanitari diventa centrale. Medici, infermieri, soccorritori, psicologi dell’emergenza operano spesso in condizioni di sovraccarico fisico ed emotivo estremo, assumendosi una doppia responsabilità: salvare vite e contenere il caos, esterno e interno. Un lavoro essenziale, spesso invisibile, raramente riconosciuto a livello simbolico e istituzionale.
La psicologia dell’emergenza ci insegna anche un’altra verità cruciale: il trauma non nasce solo dall’evento, ma anche da come l’evento viene attraversato e, soprattutto, da come viene accolto dopo. Le parole, il clima sociale, il tono del discorso pubblico possono diventare fattori di protezione oppure di retraumatizzazione.
Quando il dibattito si trasforma in una caccia al colpevole o in una graduatoria di reazioni “più mature” o “più dignitose”, si perde il punto clinico e si tradisce uno dei principi cardine dell’intervento in emergenza: non aggiungere danno al danno.
La psicologia dell’emergenza è una disciplina di confine, tra clinica, etica e responsabilità sociale. È una psicologia che sa stare nel dolore senza trasformarlo in spettacolo.
E riconosce una verità scomoda ma necessaria: nelle emergenze, la vera competenza è spesso invisibile. È fatta di silenzi giusti, presenze discrete e decisioni prese in pochi secondi che fanno la differenza tra il crollo e la possibilità di reggere.
Forse è da qui che dovremmo ripartire: dal rispetto profondo per chi interviene, per chi cura, per chi tiene insieme i pezzi quando tutto sembra andare in frantumi.
E dalla consapevolezza che, in emergenza, la prima forma di cura è non giudicare.
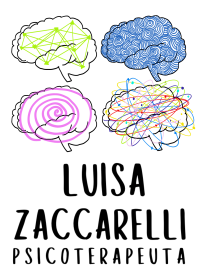
 Molti anni fa avevo trovato un video su FB, in cui passava il messaggio che le etichette di tipo neuropsichiatrico che mettimo ai bambini (DSA, ADHD, oppositivo) li limitano e che invece, proprio le loro caratteristiche li avrebbero potuti far diventare “qualcuno”.
Molti anni fa avevo trovato un video su FB, in cui passava il messaggio che le etichette di tipo neuropsichiatrico che mettimo ai bambini (DSA, ADHD, oppositivo) li limitano e che invece, proprio le loro caratteristiche li avrebbero potuti far diventare “qualcuno”.